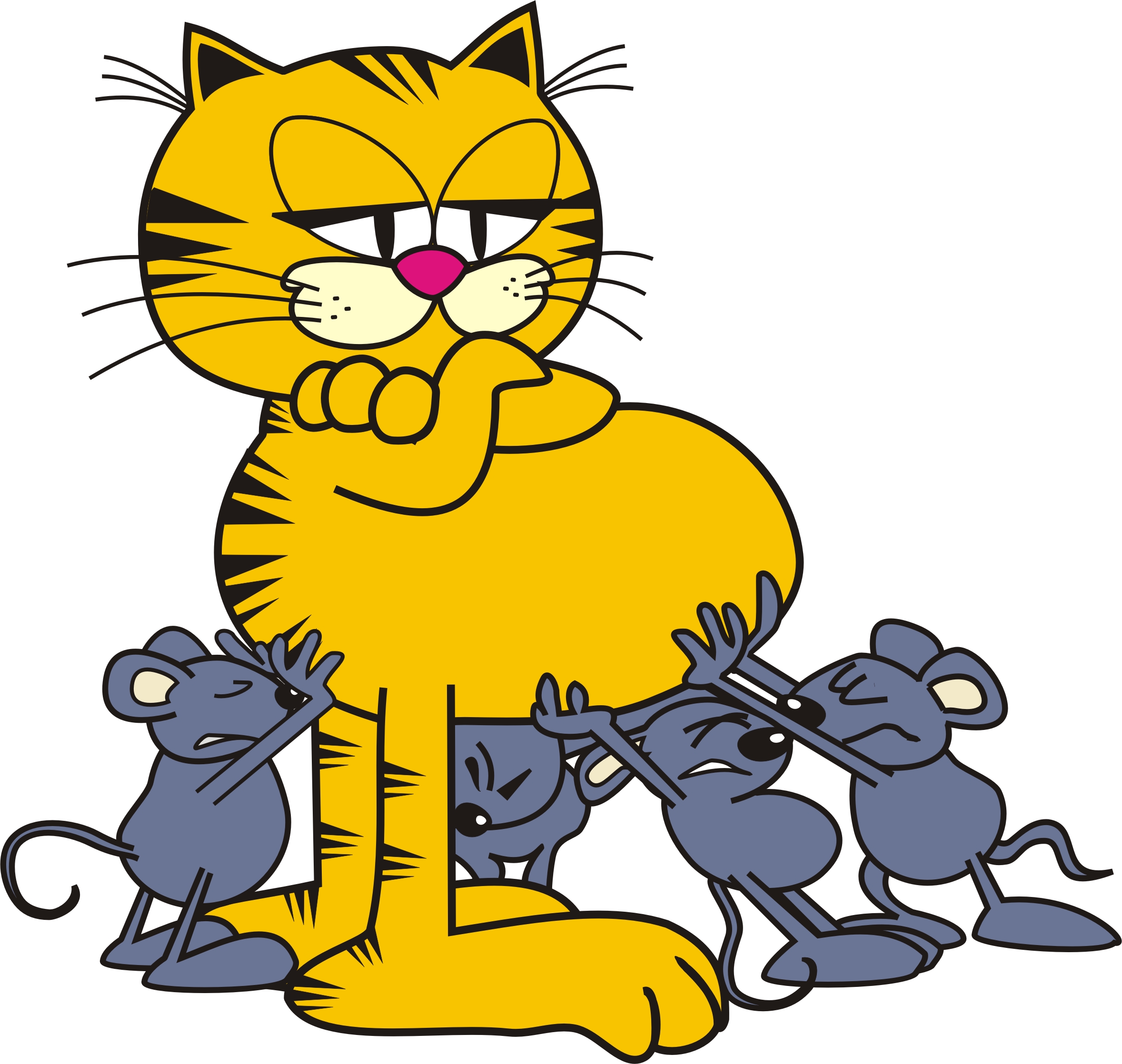Gli insetti alieni, o alloctoni, sono specie originarie di altri paesi che, per varie ragioni, si sono insediate stabilmente in ecosistemi differenti da quelli di provenienza, come ad esempio il territorio italiano. A differenza dei luoghi d’origine, dove esistono predatori naturali che ne limitano la proliferazione, in Italia queste specie trovano spesso un ambiente privo di antagonisti, che favorisce una rapida espansione.
Negli ultimi decenni, il numero di insetti alieni arrivati nel nostro Paese è cresciuto vertiginosamente. Si stima che oltre 1.500 specie si siano ormai stabilite in modo permanente, con circa 300 di esse che causano impatti rilevanti sull’ambiente o sull’economia.
La principale via d’ingresso è legata all’importazione di merci, in particolare dai paesi asiatici. Container, imballaggi e mezzi di trasporto diventano veicoli involontari di questi insetti. Anche i cambiamenti climatici giocano un ruolo cruciale: temperature più elevate rendono l’Italia sempre più ospitale per specie che in passato non avrebbero potuto sopravvivere.
Nel contesto dei giardini, gli insetti alieni rappresentano una minaccia concreta. Molti sono fitofagi e si nutrono di piante ornamentali o da frutto, danneggiando colture e spazi verdi. Alcuni competono con specie locali, spingendole verso l’estinzione, come avviene con il calabrone asiatico che attacca le api da miele. Altri, come la zanzara tigre, hanno un impatto diretto anche sull’uomo.
Prevenzione, monitoraggio e informazione sono oggi strumenti fondamentali per contenere la diffusione di questi insetti e proteggere l’ambiente, l’agricoltura e la biodiversità.
Cimice asiatica: Halyomorpha halys

La cimice asiatica (nome scientifico Halyomorpha halys) è un insetto originario dell’Asia orientale (Cina, Giappone, Corea) ed è considerata una delle specie aliene invasive più dannose arrivate in Europa negli ultimi anni.
Caratteristiche principali:
- Ha un corpo a forma di scudo, di colore marrone-grigiastro, lungo circa 1,5 cm.
- Si distingue dalla cimice autoctona per delle bande bianche sulle antenne e sulle zampe posteriori.
- È innocua per l’uomo, ma emette un odore sgradevole se disturbata.
Perché è un problema:
- Attacca oltre 300 specie di piante, in particolare frutteti (mele, pere, pesche), soia, vite, ortaggi.
- Punge i frutti e ne compromette la qualità, causando gravi perdite economiche per agricoltori e produttori.
- In autunno si rifugia nelle abitazioni cercando riparo dal freddo, causando fastidio e infestazioni domestiche.
- Come è arrivata:
- Introdotta accidentalmente tramite il commercio internazionale (container, merci).
- La prima segnalazione in Italia risale al 2012, in Emilia-Romagna, da lì si è diffusa rapidamente in tutto il Nord Italia.
- Contenimento:
- Lotta biologica con il vespa samurai (Trissolcus japonicus), un insetto parassitoide che depone le uova nelle uova della cimice asiatica.
- Reti protettive, trappole e insetticidi selettivi in agricoltura.
- Per le abitazioni: sigillare infissi, usare aspirapolvere per rimuoverle, evitare prodotti chimici all’interno.
La cimice asiatica rappresenta una sfida complessa sia in campo agricolo che urbano e richiede strategie integrate per limitarne la diffusione.
Moscerino dei piccoli frutti: Drosophila suzukii

La Drosophila suzukii, comunemente nota come moscerino dei piccoli frutti o moscerino asiatico, è un insetto originario del Sud-est asiatico, oggi diffuso in Europa, Nord America e Sud America. È una delle specie aliene invasive più dannose per la frutticoltura.
Caratteristiche principali:
- Simile al comune moscerino della frutta (Drosophila melanogaster), ma più pericoloso.
- Il maschio si riconosce per due macchie nere sulle ali.
- La femmina ha un ovopositore seghettato che le consente di deporre le uova dentro frutti sani, non solo in quelli marci o fermentati.
Frutti colpiti:
- Ciliegie, fragole, lamponi, mirtilli, more, uva, pesche e albicocche.
- I frutti attaccati marciscono velocemente e diventano invendibili.
- Ciclo biologico:
- Estremamente rapido: può compiere un ciclo completo in meno di 10 giorni.
- Le femmine depongono fino a 400 uova.
- Può sviluppare anche 13-15 generazioni l’anno.
- Danni:
- Enormi danni economici ai coltivatori di piccoli frutti.
- Difficile da controllare, perché attacca frutti ancora sulla pianta e poco prima della raccolta.
- Controllo e rimedi:
- Trappole alimentari per monitoraggio e cattura massale.
- Reti antinsetto per proteggere le colture.
- Raccolta tempestiva dei frutti maturi e distruzione di quelli infestati.
- Uso mirato di insetticidi autorizzati.
- In fase di studio la lotta biologica con parassitoidi specifici.
La Drosophila suzukii è un problema serio per la frutticoltura europea e richiede interventi precisi e continui da parte degli agricoltori per limitarne la diffusione.
Scarabeo giapponese: Popillia japonica

La Popillia japonica, conosciuta come scarabeo giapponese, è un insetto originario del Giappone e della Russia orientale, attualmente diffuso anche in Nord America ed Europa. In Italia è stata individuata per la prima volta nel 2014 e oggi rappresenta una delle specie aliene più invasive e dannose per l’ambiente e l’agricoltura.
Caratteristiche:
- Dimensioni: circa 1,5 cm.
- Corpo metallico verde-ramato con elitre bronzate.
- Presenza di ciuffi di peli bianchi lungo i lati e sull’estremità dell’addome.
- Vola fino a 8 km al giorno, facilitando la diffusione.
Ciclo vitale:
- Le larve vivono nel terreno e si nutrono delle radici di prati, colture e tappeti erbosi.
- Gli adulti compaiono in estate e divorano foglie, fiori e frutti di oltre 300 specie vegetali (vite, mais, rosa, olmo, pioppo, melo, ciliegio, ecc.).
- Attività massima: da giugno a settembre.
- Danni:
- Gli adulti scheletrizzano le foglie, lasciando solo le nervature.
- Le larve provocano ingiallimenti e moria del prato o delle colture erbacee.
- Pericoloso sia per il verde urbano che per l’agricoltura.
- Diffusione:
- Introdotto in Europa tramite container e merci.
- Si è insediato in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Valle d’Aosta.
- Favorito da inverni miti e cambiamenti climatici.
- Controllo e contenimento:
- Piani regionali con trappole a feromoni e esche alimentari.
- Controlli fitosanitari e divieto di movimentazione di piante e terriccio da zone infestate.
- In fase sperimentale l’introduzione di antagonisti naturali, come funghi entomopatogeni e nematodi.La Popillia japonica rappresenta un’emergenza ambientale e agricola che richiede monitoraggio costante e collaborazione tra enti pubblici, agricoltori e cittadini.
La Popillia japonica rappresenta un’emergenza ambientale e agricola che richiede monitoraggio costante e collaborazione tra enti pubblici, agricoltori e cittadini.
Cinipide del Castagno (Dryocosmus kuriphilus)

Il cinipide del castagno è un piccolo insetto originario della Cina, considerato uno dei parassiti più pericolosi per i castagni. Introdotto accidentalmente in Europa nei primi anni 2000, è oggi diffuso in molte regioni italiane, causando danni rilevanti sia alla produzione di castagne che alla salute degli alberi.
Caratteristiche:
- È un imenottero galligeno (simile a una minuscola vespa, 2-3 mm).
- Le femmine si riproducono per partenogenesi (senza bisogno del maschio).
- Ogni femmina depone fino a 150 uova.
Ciclo biologico:
- Le uova vengono deposte nei germogli del castagno a fine primavera.
- Le larve si sviluppano all’interno dei tessuti vegetali, formando le tipiche galle (escrescenze verdi o rossastre).
- Le galle impediscono il corretto sviluppo dei germogli, dei fiori e dei frutti.
- Gli adulti sfarfallano tra fine maggio e luglio.
Danni:
- Rallenta la crescita dell’albero.
- Riduce la produzione di castagne anche del 70-80%.
- A lungo andare può compromettere la salute e la vitalità dell’intera pianta.
Controllo e rimedi:
- Il metodo più efficace è il rilascio del Torymus sinensis, un imenottero antagonista naturale del cinipide, che depone le uova nelle larve del parassita e ne blocca lo sviluppo.
- È importante non asportare le galle dove sono stati rilasciati questi antagonisti, per non ostacolare il contenimento biologico.
- Monitoraggi costanti da parte di enti forestali e fitosanitari.
Il contenimento del Dryocosmus kuriphilus è fondamentale per la salvaguardia dei castagneti italiani, un patrimonio ambientale, economico e culturale di grande valore.
Punteruolo rosso (Rhynchophorus ferrugineus)

Il punteruolo rosso è un coleottero originario dell’Asia sud-orientale, oggi considerato uno dei principali flagelli delle palme nel bacino del Mediterraneo, in particolare Phoenix canariensis e Phoenix dactylifera. Introdotto accidentalmente tramite l’importazione di palme infette, si è diffuso rapidamente in Italia dalla metà degli anni 2000.
Caratteristiche:
- Insetto adulto lungo tra i 2 e i 5 cm, di colore rossastro con striature nere sul dorso.
- Le larve, biancastre e carnose, possono superare i 5 cm di lunghezza e sono le principali responsabili dei danni.
- La femmina depone centinaia di uova nei tessuti della palma.
Ciclo biologico:
- Le larve scavano gallerie all’interno del tronco e nella base delle foglie giovani.
- Il danno è interno e difficile da individuare finché non si manifesta esternamente.
- Le palme infestate mostrano foglie piegate o cadenti, con il classico aspetto “a ombrello”.
Danni:
- Il punteruolo compromette la stabilità e porta rapidamente alla morte della pianta.
- L’infestazione si diffonde silenziosamente, favorendo il collasso improvviso delle palme.
- Una volta attaccata, la palma è difficilmente recuperabile.
Rimedi e prevenzione:
- Trattamenti preventivi con insetticidi sistemici o biologici (ad es. nematodi entomopatogeni).
- Monitoraggio con trappole a feromoni.
- Eradicazione e distruzione delle palme infestate per evitare la propagazione.
- In alcune regioni italiane, le autorità locali richiedono comunicazioni obbligatorie in caso di infestazioni.
La lotta al Rhynchophorus ferrugineus è complessa e richiede coordinamento tra cittadini, giardinieri, enti pubblici e tecnici fitosanitari per salvaguardare il patrimonio verde e paesaggistico.
Xylella fastidiosa
xylella fastidiosa è un batterio fitopatogeno tra i più pericolosi al mondo per le piante. Originario del continente americano, è arrivato in Europa negli ultimi anni, causando gravi danni soprattutto in Italia, in particolare agli ulivi del Salento, ma anche a vite, agrumi, mandorli e altre piante ornamentali e forestali.
come agisce
Xylella colonizza i vasi xilematici della pianta, cioè quelli che trasportano l’acqua dalle radici alle foglie. Ostruendo questi canali, impedisce la corretta circolazione della linfa, causando secchezza fogliare, deperimento generale e infine la morte della pianta.
Sintomi
- Secchezza fogliare (“leaf scorch”)
- Ingiallimento o bruciature ai margini delle foglie
- Ramificazione ridotta
- Morte progressiva della pianta, partendo dalle parti più alte
Piante ospiti
Ad oggi si conoscono oltre 600 specie ospiti, tra cui:
- Ulivo
- Vite
- Mandorlo
- Rosmarino
- Lavanda
- Oleandro
Trasmissione
Il batterio è trasmesso da insetti vettori succhiatori, in particolare:
- Sputacchina (Philaenus spumarius), molto comune in Europa
Rimedi e contenimento
Attualmente non esiste una cura per Xylella. Le strategie si basano su:
- Eradicazione delle piante infette
- Zone cuscinetto per isolare i focolai
- Controllo degli insetti vettori
- Monitoraggio costante e interventi fitosanitari mirati
Impatto
Xylella ha avuto un impatto devastante:
- Ambientale, con la perdita di milioni di ulivi secolari
- Economico, per agricoltura e turismo
- Sociale, in regioni fortemente legate agli ulivi, come la Puglia
La lotta alla Xylella è oggi una delle priorità fitosanitarie in Europa, con misure drastiche per evitare la diffusione in nuove aree.
Calabrone asiatico (Vespa velutina)

La Vespa velutina, nota come calabrone asiatico, è un insetto originario del sud-est asiatico ed è considerato una delle specie aliene invasive più pericolose per la biodiversità e l’apicoltura europea.
Caratteristiche
- Corpo nero con una sottile banda gialla sull’addome.
- Zampe con estremità gialle (da cui il nome “zampa gialla”).
- Più piccola della vespa europea ma molto aggressiva, soprattutto con le api.
Perché è pericoloso
- Preda attivamente api da miele, posizionandosi davanti agli alveari per catturarle in volo.
- Una singola colonia può distruggere un intero alveare.
- La diminuzione delle api causa danni all’impollinazione e quindi all’agricoltura e all’ecosistema.
Diffusione
Introdotta accidentalmente in Francia nei primi anni 2000, si è diffusa rapidamente in:
- Italia (soprattutto Liguria, Piemonte, Toscana)
- Spagna, Portogallo, Belgio, Germania
Rimedi e contenimento
- Trappolaggio selettivo in primavera per catturare le regine.
- Distruzione dei nidi, che sono spesso sferici e costruiti in alto su alberi o edifici.
- Monitoraggio costante da parte di apicoltori e servizi fitosanitari.
Impatto
- Ecologico: minaccia la sopravvivenza delle api locali e di altri insetti impollinatori.
- Economico: danni diretti agli apicoltori e alle produzioni agricole.
- Sociale: possibile pericolo anche per l’uomo in caso di disturbo ai nidi, sebbene non sia più pericolosa della vespa comune.
Il contenimento della Vespa velutina è oggi una priorità a livello europeo, con piani di monitoraggio e intervento per limitare la sua espansione.
Coleottero degli alveari (Aethina tumida)

Il coleottero degli alveari, noto scientificamente come Aethina tumida, è un insetto originario dell’Africa subsahariana che rappresenta una minaccia crescente per le api da miele e l’apicoltura a livello mondiale.
Caratteristiche
- Piccolo coleottero di circa 5-7 mm di lunghezza.
- Corpo ovale, di colore marrone scuro.
- Predilige ambienti caldi e umidi, come gli alveari.
Perché è pericoloso
- Le larve di Aethina tumida si nutrono di cera, polline, miele e soprattutto delle uova e delle larve delle api.
- La loro presenza provoca danni diretti agli alveari e può causare il collasso delle colonie.
- Inoltre, la loro attività favorisce lo sviluppo di muffe e microrganismi patogeni.
Diffusione
- Originario dell’Africa, si è diffuso in America (Stati Uniti, Canada), Australia e recentemente in Europa, dove sono stati segnalati casi isolati.
- La diffusione avviene principalmente tramite il trasporto di api infette o materiali apistici.
Rimedi e controllo
- Ispezioni regolari degli alveari per individuare la presenza del coleottero.
- Trappole specifiche per adulti e larve all’interno degli alveari.
- Misure di quarantena e controllo ai confini per prevenire ulteriori introduzioni.
- In alcuni casi si interviene con trattamenti chimici autorizzati e procedure di pulizia approfondita degli alveari.
Impatto
- Ecologico: minaccia la salute delle colonie di api, essenziali per l’impollinazione.
- Economico: danni all’apicoltura e alle produzioni di miele.
- Agronomico: rischio per l’impollinazione delle colture.
La prevenzione e la gestione rapida di Aethina tumida sono fondamentali per salvaguardare la biodiversità e le attività apistiche.
Zanzara tigre (Aedes albopictus)

La zanzara tigre, scientificamente chiamata Aedes albopictus, è una specie di zanzara originaria delle regioni tropicali del Sud-Est asiatico, oggi diffusa in molte aree temperate, inclusa l’Italia.
Caratteristiche
- Piccola, di colore nero con strisce bianche lungo il corpo e le zampe, da cui il nome “tigre”.
- Attiva principalmente diurna, a differenza delle zanzare comuni.
- Predilige ambienti urbani e suburbani, dove trova facilmente piccoli ristagni d’acqua per la deposizione delle uova.
Perché è pericolosa
- È vettore di diverse malattie virali, tra cui dengue, chikungunya, zika e febbre gialla.
- La sua puntura è fastidiosa e può provocare reazioni allergiche in soggetti sensibili.
- Ha un ciclo di vita rapido e una grande capacità di adattamento, facilitando la sua diffusione.
Diffusione
- Introdotta in Europa negli anni ’90 tramite il commercio di pneumatici usati e piante ornamentali.
- Ora presente in molte regioni italiane, soprattutto in estate.
- Si sviluppa in piccoli contenitori d’acqua stagnante come sottovasi, grondaie, pozzetti.
Rimedi e prevenzione
- Eliminazione o trattamento dei ristagni d’acqua vicino alle abitazioni.
- Uso di zanzariere e repellenti cutanei.
- Campagne di monitoraggio e disinfestazione da parte delle autorità sanitarie.
- Informazione e sensibilizzazione della popolazione.
Impatto
- Problema di salute pubblica per la trasmissione di malattie.
- Disagio e riduzione della qualità della vita per le punture frequenti.
La lotta alla zanzara tigre richiede la collaborazione tra cittadini, enti locali e autorità sanitarie per limitare la sua diffusione e ridurre i rischi.